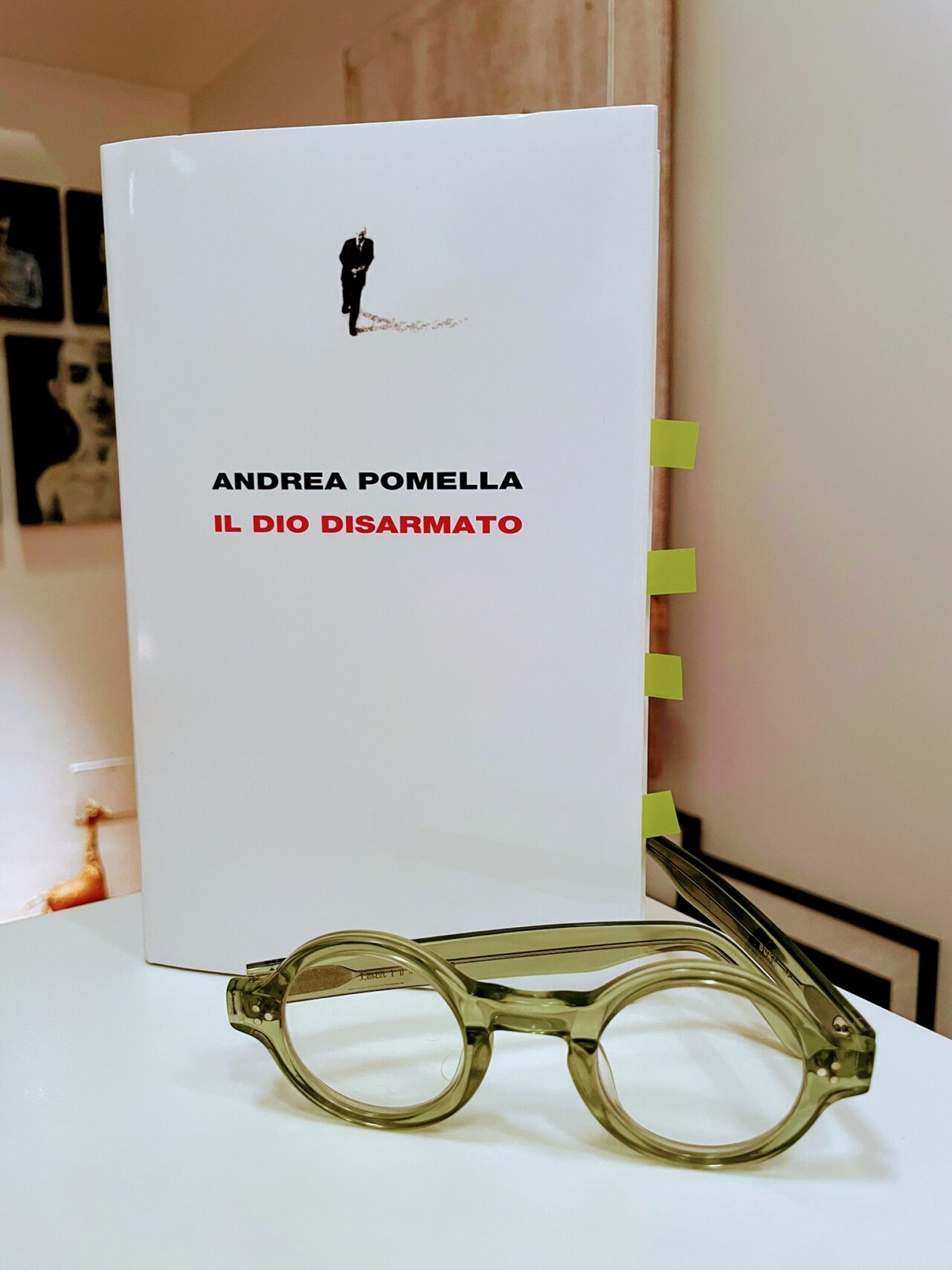I libri scelti da Andrea Salonia
_________________________________________________________________________
Ci sono momenti che non si dimenticano, mai.
O almeno per me è così. Meglio: le immagini, i suoni, i rumori; le luci; i neri e i bianchi; il verde del prato; il grigio della pioggia battente; i colori tutti; il cicaleggio delle parole attorno; le persone uscite dalla TV, con le strisce rosse sul fianco delle ambulanze, quando hai sette anni e a parte Actarus e Goldrake, Heidi e il cane Nebbia, non hai nella testa – non dovresti avere! – orizzonti di torva infelicità, ma la sola preoccupazione delle avventure del pomeriggio e i robot giganti e le caprette e le altalene che ti proiettano direttamente in cielo come il razzo, sempre rosso, di Tin Tin (senza neppure sapere chi fosse quel genio di Hergé). E invece l’immagine che ti rimane in mente è quella di una automobile, una Renault 4 con quella sua forma buffa e vecchia insieme, pure lei rossa, e di quel signore nel baule, vestito di tutto punto ma messo male, accartocciato. E la gente, tutti quei curiosi, con le macchine fotografiche, senza macchine fotografiche, in molti moltissimi coi baffi che pare nessun uomo ne possa fare a meno, e tutti loro attorno a sbirciare quel signore li dentro. Musoni un poco tutti, con quelle facce – perché a sette anni son facce e non volti e tantomeno visi – che stan nel mezzo tra la preoccupazione e la tristezza. E pure quelle ti rimangono nella memoria, assieme alla loro curiosità che a valle ti sembrerà ossessiva, noiosa, invadente e intollerabile: lasciate morire quel povero corpo (dirai).
Ecco, ci sono momenti che non si dimenticano, mai.
Per me è così, certamente. Forse perché ho un elefante nella testa, e spesso mi muovo e agisco tra i cristalli con scarsissima delicatezza, e insieme all’elefante in testa ho pure la sua memoria, principalmente per le cose brutte. Forse perché la mia generazione di bambino negli anni settanta ha tatuata la storia del signor Aldo Moro, il Presidente di qualcosa che non capivamo neppure bene cosa fosse, e che un brutto giorno era stato rapito da alcuni altri signori che avevano pensato di ricattare la nazione il mondo intero gli amici e i nemici del signor Presidente la sua famiglia i suoi figli suo nipote la nostra mamma e il nostro papà, e noi tutti, perfino noi bambini. E la maestra ci spiegava che bisognava aver timore ma non aver paura di quella gente, che pure quelli eran rossi, ma nel nome principalmente: Brigate Rosse. Quelle sono le immagini che rimangono indelebilmente tatuate addosso, fors’anche più di questi sfavillanti tatuaggi di cui oggi l’ottanta per cento dei bipedi senzienti sembra non poter fare a meno. Come dei baffi negli anni settanta, sotto il naso degli uomini, ragazzi, giovani adulti, giovinetti, di mezza età e nonni, che nell’insieme parevano tutti sempre più anziani e molto più maturi di quanto fossero. Brigatisti compresi. Anche noi bambini, risvegliati d’obbligo dai sogni e dai giochi, dai mostri colorati arrivati dagli spazi siderali, e senza neanche il Grande Mazinga di turno, ben saldo sui suoi piedoni a proteggerti. Sfido chiunque tra noi cinquantenni di oggi a non avere quelle memorie fossili nella memoria, addormentate dentro la mente come gli insetti nell’ambra, che paion vivi per tanto che son ben conservati. Immortalizzati senza neppure che se ne fossero resi conto, tranquilli in una colata di resine tra il biondo e l’arancione. Noi pure, con quell’automobile rossa, la sigla del Telegiornale, il piombo e i suoi anni attorno a far da coperta per il freddo, il proiettile nelle gambe di qualcuno senza neppure che vi fossero gli indiani d’America a inseguire i cow boys e viceversa, senza – soprattutto – che avessimo capacità critica bastante a razionalizzare l’orrore, e a dargli giusti confini.
Quelli sono i momenti che ogni volta che si torna a parlare di Brigate Rosse e di quegli anni riaffiorano alla mente. Quello è ciò che, prepotente, si è materializzato di nuovo in questi ultimi giorni nel leggere “Il dio disarmato” di Andrea Pomella, edito da Einaudi. L’ho acquistato per la copertina tutta bianca e quell’omino in cima, nero che di prim’acchito pare uno scarabocchio. Solo, solissimo. E credo questo basti a raccontare tutto ciò che capitò. O almeno questo è quanto mi sembra di aver capito.
Ma “Il dio disarmato” è altro. Pomella prova a raccontare l’intimità degli eventi e degli avvenimenti. Il tepore, la coscienza, l’interiorità, l’ambiente accogliente, il letto di Heidi nella casa del nonno sull’alpe. E pure il disincanto, i vetri rotti, il claudicare dei giorni, la testa china sui libri. Il sudore acre dei preparativi che precedono i grandi eventi. Il tessuto delle poltrone di casa, liso per il tanto sedersi. L’ambiguità di fondo che la malattia sempre possiede – questo, da medico, mi ha tanto colpito nelle parole dello scrittore – di quella malattia che procura una certa qual debolezza nell’organismo che a sua volta invita alla accettazione del proprio destino di solitudine, “alla soddisfazione di sorvegliare il mondo dall’alto, di trionfare su coloro che sono sani e non sanno, e che perciò continuano a dimenarsi convinti dell’eternità della loro forza e della loro salute” (cit).
Da bambino mi sarebbe tanto piaciuto che Goldrake scendesse a prendermi, anche giusto per un attimo soltanto, così che il mondo fosse laggiù, in basso, e io lo potessi vedere da lassù per come poteva apparire dal lontano e non per com’era realmente.
Credo “Il dio disarmato” vi potrà piacerà.
_________________________________________________________________________________________________
Andrea Pomella, Il dio disarmato, Einaudi, Torino, 2022